di Alberto Castaldini
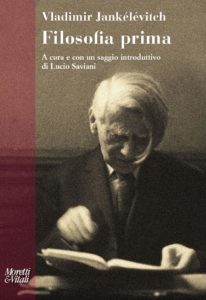
La Philosophie première. Introduction à une philosophie du presque (1954) di Vladimir Jankélévitch (1903-1985) ci rivela in tutta la sua forza discorsiva e, al contempo, nella sua complessità, la “filosofia della vita” di questo pensatore francese di origine russo-ebraica. Essa sgorga dalla dimensione del vissuto nella sfera cosciente e subito si rivolge all’esperienza umana, non con una prospettiva contemplativa bensì attraverso una tensione teoretica pronta a inseguire, all’improvviso, quella fattualità che è l’attuarsi stesso della realtà vitale. Del resto, nella riflessione del filosofo che per un quarto di secolo tenne la cattedra di filosofia morale alla Sorbonne, l’intera realtà, e con essa l’esistenza degli uomini, è immersa in un susseguirsi di istanti che non si possono afferrare, seguiti da intervalli come le note su di uno spartito che dal tanto ricercato piano dell’essere scivola immediatamente in quello del “far-essere” il cui contenuto morale, che comprende l’amore, è anzitutto per l’Altro. L’atto nell’altruità rappresenta infatti per Jankélévitch l’unica trascendenza possibile. Su questo punto centrale torneremo più avanti.
Di Filosofia prima è stata pubblicata la prima edizione italiana, curata e introdotta da Lucio Saviani, con la traduzione di Francesco Fogliotti. Impresa editoriale impegnativa, che colma un vuoto consistente nelle traduzioni in italiano dell’opera del filosofo. “La mia metafisica”: così Jankélévitch definì quest’opera con un malcelato, quasi provocatorio, candore teoretico, dettato dal fatto che l’unica metafisica per lui praticabile – cioè pensabile – si relaziona al mistero che è incommensurabile e perciò innafferrabile. Lucio Saviani nel suo saggio introduttivo fornisce al lettore gli accordi utili a fissare, nella musicalità rapsodica ma coerente della scrittura jankélévitchiana, quello che è il Leitmotiv di Filosofia prima: la forza ri-velatrice dell’istante. Saviani rinvia da subito (p. 9) a un saggio critico di Jean Wahl, apparso l’anno dopo la pubblicazione di Filosofia prima sulla “Revue de Métaphysique et de Morale”. Wahl ricorda che in quest’opera è l’istante che palesa la filosofia.
Rinnovato “battito di ciglia”, esso sembra distogliere lo sguardo per poi attirarlo nuovamente in una sequenza di riflessioni che somigliano talora all’impianto della forma-sonata sciolta però da canoni classici. Che Jankélévitch abbia nutrito un grande interesse per la musica è cosa nota, ma l’assenza di una struttura espositiva di carattere logico, ‘sacrificata’ all’imprevisto affacciarsi di variazioni sul tema dell’indicibile, da un lato rende complesso l’approccio all’opera, dall’altro ripaga il lettore, spesso in modo inatteso, con squarci sull’ineffabile che il filosofo francese riesce comunque ad esprimere e riannodare (e in ciò va riconosciuto merito alla versione offerta dal traduttore), in un succedersi di riflessioni che partono da un presupposto: quel nescio quid che non è una resa, ma l’unico sguardo possibile sul volto invisibile di Dio, che è limite per la ragione e “serietà metafisica” al cospetto del Mistero.
Agli squarci sull’ineffabile si susseguono salti, balzi ‘metafisici’, con i quali si passa dal piano empirico alla prospettiva meta-empirica che tale rimane, irraggiungibile nella sua proiezione senza-fine al cospetto del quasi-niente (Presque-rien). In questo si colloca, di continuo, una “mutazione radicale, una conversione” – scrive puntualmente Saviani – giacché “è necessario che i due estremi restino tenuti nella loro radicale differenza qualitativa, la quale tuttavia non determini una loro incomunicabilità” (p. 13). Il “contatto” avviene attraverso lo “slancio”, il “salto”: “folgorante movimento istantaneo” che accende la conversione in una frazione di tempo che svela e ri-vela, “lampo” metafisico che è – non ci si illuda – esclusiva intuizione, nell’attimo in cui “la dimensione materiale e quella spirituale si incontrano senza trattenersi e senza alcuna propedeutica” (p. 14).
Per Jankélévitch ha una grande importanza ispiratrice, nella visione/pensiero sull’incolmabile abisso, l’immagine della caverna e dei suoi prigionieri nel settimo libro della Repubblica di Platone. La loro torsione conoscitiva verso la luce che proviene dall’esterno, movimento deciso, di scatto, somiglia alla conversione senza ripensamenti (cfr. l’ebr. teshuvà, dal verbo la-shuv, “ritornare”) per la filosofia prima, protesa con tutta l’anima “verso l’idea del bene”, per confutare i “falsi metafisici”, pensando “l’incomparabile mantenendolo impensabile” (p. 15), perché il metafisico serio deve sì pensare il mistero, ma conservandone l’incertezza, senza illudersi o illudere di parlare, o peggio ancora, di osservare, sul “fondo dell’essere” come se fosse parte del mondo reale e come tale palpabile in quanto sostanza.
In questa presa di coscienza del limite di ogni metafisica, pur non rinunciando all’aspirazione di affacciarsi, per un attimo, sull’abisso di Eyn Sof che è l’Infinito divino prima di ogni sua possibile auto-manifestazione, l’opera di Jankélévitch si colora di molteplici note ispiratrici, balenanti – le enumera Saviani – da fonti “platoniche, neoplatoniche, agostiniane, ebraiche, slave” (p. 18). Fra queste ultime ricordiamo i grandi pensatori russi (Berdjaev, Florenskij, Šestov, Solov’ëv) e, accanto, gli scritti dei Padri greci e cappadoci (s. Giovanni Crisostomo, s. Gregorio di Nissa), cui si aggiungono i mistici tedeschi (dove le peregrinazioni cherubiche presentano non poche affinità con gli affacci cabalistici sull’Ineffabile) e la teologia negativa.
Saviani sottolinea poi l’importanza di quella condizione del “sempre altrove” (p. 18), costitutiva della coscienza ebraica e che permea molti degli squarci metafisici di quest’opera, nonostante il suo approccio sia fondamentalmente neoplatonico. Ma l’altrove, che prima o dopo determina una ricerca, un cammino, inevitabilmente conduce al cospetto di quella Presenza, spesso incomprensibile per l’uomo nelle sue richieste o nelle sue affermazioni, che si manifestò improvvisa e non facilmente riconoscibile sul Moria, sull’Oreb o all’ombra delle querce di Mamre. E Saviani propone di descrivere il rapporto fra trascendenza e immanenza nel filosofo francese come un “dissenso” (Jankélévitch lo definisce musicalmente “dissonanza”) (p. 22). Ci sembra un’immagine corretta, sia perché – come spiega il curatore – la filosofia deve avere sempre qualcosa da ridire, sia perché al cospetto dell’Assoluto ogni possibile domanda, ogni meraviglia come ogni delusione, non possono che generare una contrarietà feconda, simile a quella del pilpul rabbinico (diversamente, l’esito dialettico della disputa è totalmente estraneo al nostro pensatore, profondamente segnato da Bergson, anch’egli peraltro con radici familiari nell’Europa orientale ashkenazita, ma meno affioranti).
Filosofia prima è una sequenza di dieci capitoli, tradotti con amore filologico da Fogliotti, che col curatore si è costantemente confrontato, avvalendosi inoltre – in fase di revisione – delle competenze di grecisti e slavisti. La traduzione di quest’opera non è solamente un’impresa linguistica, ma un instancabile esercizio al pensiero, come ebbe ad affermare lo scrittore, poeta e traduttore dall’ebraico biblico Guido Ceronetti (1927-2018), alla cui memoria Fogliotti ha dedicato il suo lavoro. Ed è un esercizio al pensiero anche la sua lettura, non certo facile, ma proprio per questo corroborante anche per chi vuole dissentire dal dissonante dissenso metafisico di Jankélévitch.
Nella ri-velazione jankélévitchiana del mistero incombe la consapevolezza della morte, con cui il pensiero non può non misurarsi nel tentativo (vano) di sopravviverle (p. 81). Ma nonostante questo con-fine esistenziale, la vocazione soprannaturale pare “indissolubile”, e il “mistero pensante” si incarna in un’“eternità-mortale” che, come tale, è destinata per l’Autore a rifluire nel non-essere (p. 82). Quello di Jankélévitch, infatti, non è un esser-ci per la morte, giacché nell’amore (il far-essere nell’altruità) diventa mistero di rinascita, di rinnovamento oltre che continuità della specie (p. 84), e, ancora, perché la morte – almeno sul piano teorico – non coinvolge contemporaneamente tutti e tutto.
E poi c’è l’intuizione, che è quel lampo “che lacera la notte” (p. 106), istante che ha la luce durevole di una scintilla, la quale è “rinascita che muore”, “una morte che è una vita”: per essa il mistero pensante quasi si ri-vela, prima di sprofondare in quel vuoto che vuoto non è, perché Dio resta insondabile e, anche se viene negato, persiste nell’uomo l’intenzione a “pensare la verità” (p. 109).
Resta sullo sfondo (che non ha fondo) quel “Totalmente-altro” che colma il cap. V dell’opera, così simile all’Eyn Sof (e dunque a una trascendenza così inafferrabile da mostrarsi inconsistente) della visione cabalistica, incomprensibile interlocutore di ogni filosofia e teologia negativa (pp. 150-151), “colui per il quale tutta l’essenza è di essere altro”, e che, “se così possiamo dire” – scrive Jankélévitch usando curiosamente un’espressione dubitativa rabbinica: kivjaqôl – è “totalmente-altro in sé e per vocazione” (p. 159). Ciò al punto da sottrarsi a ogni resa semantica della definizione personale che Dio fa di sé dal roveto ardente in Esodo 3,14 (contrapposto dall’Autore a Enneadi V, 3,13).
A Mosè, del resto, non fu mai concesso di vedere Dio in volto (ma di spalle, per scorgerlo quasi: Esodo 33,22-23); parimenti ai Settanta – ad avviso dell’Autore – non era lecito sostituire nella traduzione greca di Èyèh ashèr Èyèh “l’esistente neutro” con la “persona esistente” (p. 167). Jankélévitch, rifiutando ogni antropomorfismo, aderisce infatti alla ‘visione’ plotiniana: “Dio non è nemmeno Dio; Dio è più di Dio, Dio è altro da sé” (p. 166); è “ipsesità delle ipseità”, mistero inconoscibile, di nescienza (con “Nescioquid” egli lo condensa) (p. 180) che “non è più facile da circoscrivere di quanto lo sia l’anima”, scrive citando un’omelia di san Giovanni Crisostomo (p. 189).
Per quanto possa risultare apofatico l’approccio del filosofo francese, il cap. IX, intitolato La creazione, sembra fortemente debitore alla lezione di Bereshit, in quel movimento che “offre e pone” la “donazione creatrice” (p. 229), e che precede persino il chaos (tohu va-bohu) (p. 235) in quanto iniziativa prima che proviene da Infinito, intuizione primordiale, eterno battito di ciglia che con-fonde Inizio e Fine, poiché se l’istante è “per l’uomo la ‘durata’ intemporale o supra-temporale del Far-essere miracoloso”, “la creazione è interamente l’istante stesso” (p. 250) che si misura (e si confonde) a sua volta “col mistero della morte” (p. 256).
Concludendo, Jankélévitch con la sua metafisica ha sperimentato, e ci fa sperimentare, la “vertigine metafisica che s’impadronisce dell’uomo in presenza del mistero senza nome” (p. 271) che “è totalmente creazione”, e che non contempla domande con risposta, ma è eterna domanda di fronte al far-essere (cfr. pp. 273-275). E proprio all’uomo, intermediario del mistero, è dedicato l’ultimo capitolo della Philosophie première (la cui ultimità è in realtà ri-avvio per nuovi percorsi metafisici interrotti).
La somiglianza teandrica di Genesi (1,27) si risolve nel “creare, cominciare, donare”: “istanti” riassunti “nel gioioso movimento dell’amore, che è la riposizione umana della posizione fondatrice” (p. 303). Il mistero sembra o è quasi svelato: l’uomo lo sfiora, e per un attimo lo trattiene con l’intuizione creatrice, lo vive nell’istante generoso, ingannando la morte con la speranza gioiosa che l’Inizio continui.
Vladimir Jankélévitch, Filosofia prima. Introduzione a una filosofia del “quasi”
A cura e con un saggio introduttivo di Lucio Saviani, trad. it. di Francesco Fogliotti (Moretti & Vitali, 2020, pagine 311, euro 25,00).
Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto e provvederemo alla sua cancellazione dal sito




